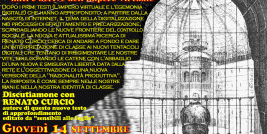Il 1975 fu un anno molto particolare.
Si andava affermando in maniera sempre più eclatante una pesante crisi strutturale del modo di produzione capitalistico; era già da tempo finito, infatti, il boom economico quando la fase di ricostruzione post bellica e la forte accelerazione di un processo di industrializzazione, basato su un economia di scala, avevano permesso una fortissima accumulazione di profitti per una rinata borghesia nazionale.
Questa nuova accumulazione di profitti aveva permesso, all’insegna delle teorie keynesiane, un intervento statale sempre più massiccio e una redistribuzione progressiva del reddito per una forte spinta ai consumi interni, ma era anche servita ad imporre, a un paese che usciva devastato dalla guerra e dal ventennio fascista, una sorta di patto sociale che prometteva la diffusione di maggior benessere, con l’allargamento del numero dei salariati in cambio di livelli di sfruttamento e profitti sempre maggiori.
La grandi crisi energetica dei primi anni ’70 spinse, però, ad una forte impennata dei prezzi di consumo e, congiunturalmente, i governi dell’epoca, applicarono delle dissennate politiche svalutative che, abbassando il valore della lira, incrementarono esponenzialmente l’abbassamento del potere d’acquisto dei salari, causando così un forte peggioramento delle condizioni di vita per i lavoratori, le lavoratrici, e le loro famiglie.
Questo scossone fu però troppo profondo da potersi risolvere o governare con la scelta di politiche economiche usuali, definendosi, chiaramente, come indice di una crisi strutturale.
Incominciava infatti, a cavallo degli anni ’70, quel processo epocale di trasformazione dell’organizzazione capitalistica del lavoro, che dava il via alla distruzione sistematica delle grosse concentrazioni industriali consone ad un sistema produttivo di tipo fordista, provando a ristrutturarlo per sopravvivere alle prime grosse crisi di sovrapproduzione e saturazione dei mercati, tentando di scaricarne i costi sulle classi subalterne. La variabile su cui immediatamente intervenire era ieri, come oggi, il costo del lavoro insieme al sistema generale di garanzie sociali, cercando anche di spezzare, come elemento di forzatura tutta politica, quella stratificazione di diritti sostenuta dalla modificazione dei rapporti di forza nelle fabbriche, acquisita con le lotte dell’autunno caldo che portarono alla formalizzazione e al riconoscimento dello Statuto dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Questo progressivo peggioramento delle condizioni di vita causò una forte e spontanea protesta popolare.
Ondate di scioperi attraversarono tutta l’Italia, e la radicalizzazione di questi conflitti tendeva ad esprimere posizioni sempre più chiaramente anticapitalistiche che, sfondando i limiti ed i paletti che le organizzazioni sindacali ponevano alle lotte, ne spostavano oggettivamente le prospettive su un terreno politico sempre più avanzato.
Tra mille contraddizioni e difficoltà, si definiva la progressiva consapevolezza di un’identità della classe come soggetto storico capace di una trasformazione dell’esistente, e venivano a maturare i frutti di uno sforzo ricompositivo sul terreno concreto dello scontro di classe, ad esempio studenti e lavoratori, che arrivava dalle lotte dell’Autunno caldo del ’69.
L’idea stessa di Comunismo, di una società nella quale potesse trovare risposta l’esigenza di liberazione dal lavoro salariato, la sua affermazione esplicita di egualitarismo economico e sociale, l’idea di un’unica condizione imprescindibile per la valorizzazione delle potenzialità di ogni essere umano, la necessità di una radicalizzazione delle lotte in relazione all’espressione di una capacità di esprimere un conflitto di classe sempre più dispiegato, l’utilizzo della forza e della “violenza” come strumento di ribaltamento dei rapporti di classe, ecco questi fattori erano presenti da anni nel dibattito che attraversava, non solo la sinistra rivoluzionaria, ma gli stessi soggetti sociali che erano protagonisti del conflitto nella consapevolezza che l’idea, il sogno, l’utopia, la “voglia” di comunismo fossero oggettivamente indispensabili per avanzare o anche solo resistere sul piano economico agli attacchi del padrone. Ma, come nel 1969, la risposta della classe padronale italiana non si fece attendere.
Revisionismo storico e strategia della tensione
In una fase cosi particolare di revisionismo e di ricostruzioni storiche cosi falsate e di pacificazioni così propedeutiche per la destra e non solo, crediamo fondamentale ricordare che le tanto decantate “istituzioni dello stato democratico”, la cosiddetta difesa delle quali era il terreno sul quale si definivano gli accordi di compromesso storico, non si spinsero su un terreno d’involuzione autoritaria per frenare una “guerra tra estremismi”, ma che eravamo ancora nel pieno di una precisa strategia della tensione che, con bombe, attentati e omicidi nelle piazze, mirava a bloccare quelle grandi lotte di massa che la classe operaia e contadina portavano avanti, rivendicando il diritto ad un futuro migliore. I disegni repressivi della borghesia erano così espliciti fino ad arrivare a più o meno plausibili colpi di stato, (ricordiamoci quello dei colonnelli in Grecia del 1974, e i costi in vite umane pagati dal popolo greco) che comunque servivano alla restaurazione di un clima d’ordine contro le proteste sociali.
Si era affermato nei fatti, dopo il fascismo e la seconda guerra mondiale, il terrorismo di Stato come nuova strumento tattico in mano al capitalismo italiano, per soggiogare le aspirazioni e le spinte alla trasformazione in maniera tale da prevenire e reprimere eventuali processi d’aggregazione di forza di classe, anche non soggettivamente rivoluzionari, nel momento in cui l’egualitarismo non rappresentava più solo una parola evocatrice di un immaginario di libertà, ma un terreno concreto di lotta di un proletariato che si riappropriava con determinazione dell’unico strumento nelle nostre mani per superare difficoltà e contraddizioni: il conflitto di classe.
E la risposta non si fece attendere: nel solo 1975 numerosi compagni versarono il loro sangue assassinati da carabinieri, polizia e fascisti.
Violenza di stato
Questo salto di qualità della violenza di stato incominciò a Milano il 16 aprile, quando il giovane e generoso compagno Claudio Varalli, di ritorno con altri compagni e compagne da una manifestazione per il diritto alla casa, veniva assassinato con alcuni colpi di pistola sparatogli alle spalle da un gruppo di fascisti.
Subito la rabbia delle centinaia di compagni accorsi si concentrò sulla sede del Giornale, diretto da Indro Montanelli, che accreditava la versione della rissa tra bande sostenuto dalle veline della Questura.
Il giorno dopo un enorme corteo, in cui dolore e rabbia si potevano leggere negli occhi lucidi dei compagni e delle compagne, partì da piazza Cavour, dove erano ancora visibili le tracce del sangue versato da Claudio, per mettere in pratica quella parola d’ordine che attraversava in quegli anni tutti i movimenti: le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco.
Fin dalla mattina presto, ogni bar punto di ritrovo degli squadristi del Msi, ogni sede, ogni giornale della destra venne bruciato e raso al suolo per protesta per l’assassinio di Claudio.Ma rimaneva ancora in piedi l’obiettivo più importante e significativo, la sede del Msi di via Mancini, da dove quotidianamente partivano le squadracce fasciste per aggressioni a chiunque si connotasse, anche solo per l’abbigliamento, come “di sinistra”. Il corteo, dal centro di Milano, si volse in maniera determinata verso piazza Cinque Giornate e, con lunghissime ondate di rabbia, spazzò via Mancini e i numerosi blindati di carabinieri e polizia posti inutilmente in sua difesa. Dopo l’ultima ondata, mentre il corteo si ricompattava, una carica a ventaglio compiuto da una decina di camion dei carabinieri spazzava, salendo anche sui marciapiedi, tutto il corso XXII Marzo, investendo un gruppo di manifestanti e schiacciando in velocità il compagno Giannino Zibecchi.
Quest’assassinio avvenuto il giorno dopo quello di Claudio fu straziante e colpì come un macigno la coscienza e il cuore di tutti i compagni e le compagne indistintamente di tutte le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria di quegli anni, e questo fu evidente nell’assemblea cittadina che si tenne poche ore dopo alla Statale, e in quell’incredibile fiume di pugni alzati e bandiere rosse che fu il funerale di Giannino nei giorni successivi. Un unico corpo fatto da decine di migliaia di compagni, che colpito in maniera così violenta, trovava la forza di reagire con il calore della solidarietà e della lotta comune contro la prevaricazione e la violenza di una società basata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Ma qui vogliamo fermare il racconto, perchè queste riflessioni non vogliono essere una retorica commemorazione di due compagni caduti per il comunismo, ma hanno senso solo se vogliamo provare a ricostruire il senso complessivo di quel momento storico.E infatti la fase di scontro era tale che non bastarono le vite di questi due compagni per sfamare il mostro del terrorismo e della violenza di Stato che era già arrivato al 1975 lasciando una lunga scia di morte.
Senza risalire fino alla strage di Portella della Ginestra o ai morti del luglio ’60 vogliamo però ricordare i braccianti Giuseppe Scibilia ed Angelo Sigona assassinati ad Avola nel 1968, i sedici morti in piazza Fontana il 12 Dicembre 1969, Giuseppe Pinelli assassinato alla Questura di Milano tre giorni dopo, il 15 Dicembre 1969, Saverio Saltarelli ucciso da un candelotto lacrimogeno in pieno petto il 12 Dicembre 1970 a Milano, il pensionato Giuseppe Tavecchia colpevole di passare vicino ad un corteo durante le violente cariche della polizia l’11 marzo 1972 nel centro di Milano. Franco Serantini ammazzato a calci e a bastonate il 5 Maggio 1972 nel carcere di Pisa, Mario Lupo assassinato a Parma da una squadraccia fascista il 5 agosto del ’72, Roberto Franceschi ucciso nel gennaio del ’73 vicino alla Bocconi da colpi di pistola della PS, Vincenzo Caporale nel febbraio dello stesso anno a Napoli da un candelotto e la vita di Fabrizio Ceruso stroncato a Roma dal piombo di stato l’8 settembre 1974, gli 8 morti della strage in Piazza della Loggia nel maggio 1974 a Brescia e ancora i 12 morti per la bomba sul treno Italicus nell’agosto 1974...
Ma quel 1975 di sangue continuava lasciando a terra il 18 Aprile, colpito da un proiettile di un poliziotto Rodolfo Boschi durante le manifestazioni di protesta per l’assassinio di Claudio e Giannino a Firenze, e Tonino Miccichè dirigente di Lotta Continua e dirigente del movimento dell’occupazione delle case a Torino, e poi Alberto Brasili accoltellato il 25 Maggio in piazza San Babila a Milano, “colpevole” di indossare un eskimo ed essersi avventurato nel territorio di caccia preferito dalle squadracce dell’MSI, ed ancora Piero Bruno che chiudeva nel novembre 1975 a Roma gli assassinii di quell’anno
E poi ci furono ancora Mario Salvi assassinato il 7 Aprile del ’76 da una pistolettata alla nuca di un P.S. durante gli scontri al tribunale di Roma dopo la sentenza fascista contro il compagno Marini, Gaetano Amoroso ucciso a coltellate a Milano il 27 Aprile 1976 da sette militanti del MSI tra cui Gilberto Cavallini, terrorista NAR e amico di Pasquale Guaglianone candidato alle elezioni regionali del 2005 per AN, e Francesco Lorusso fucilato alle spalle da un plotone di carabinieri a Bologna l’11 Marzo 1977, e poi ancora Giogiana Masi e Walter Rossi assassinati a Roma il 12 marzo e il 30 settembre 1977 rispettivamente dalle squadre speciali di Cossiga e da una squadraccia fascista, ed ancora Valerio Verbano ammazzato da un gruppo di NAR sotto gli occhi dei genitori il 28 Marzo 1980 a Roma e Luca Rossi il 23 febbraio del 1986 vittima della legge Reale a Milano.
Fino ad arrivare a Fausto e Iaio nel Marzo del 1978 a Milano e dopo ancora Carlo Giuliani a Genova nel luglio del 2001, il giovane militante antifascista Davide Cesare Dax accoltellato a morte nel Marzo 2003 a Milano, Renato Biagetti il 29 agosto 2006 a Focene, vicino Roma, e Nicola Tommasoli nel maggio 2008 a Verona ucciso da alcuni militanti di Forza Nuova per il suo look ritenuto "alternativo". Per non continuare con l’elenco lunghissimo dei morti delle organizzazioni combattenti vittime, negli anni ‘70/80, di agguati dei reparti scelti dal Generale Dalla Chiesa come ad esempio l’esecuzione a freddo di Mara Cagol, di Walter Alasia e la strage di Via Fracchia a Genova, solo per citare alcuni esempi.
Questa è la nostra storia.
Un pezzo di storia della lotta di classe in Italia, una storia che, nella narrazione di ognuno di quelli che l’hanno vissuta, molte volte purtroppo viene ricostruita a seconda delle proprie esperienze o appartenenza, ma che non può comunque mai e in nessun caso essere lasciata in mano o rinchiusa in versioni consone agli interessi del dominio di classe. Un pezzo di storia da cui noi tutti in qualche maniera nasciamo o siamo influenzati, che non va enfatizzata ne edulcorata o vista come qualcosa di lontano, ma sentita e considerata come nostra matrice, il cui processo dialettico e la cui sconfitta o chiusura di fase, a seconda delle interpretazioni, ci conduce, proprio per il non tenerne conto, alla devastazione politica culturale dell’oggi.
Ma non abbiamo voluto ricordare questo lungo elenco di nomi e non abbiamo rievocato questi volti solo per dare uno scossone a molte coscienze intorpidite. Crediamo che ricordare Claudio e Giannino e tutti gli altri nostri compagni e compagne assassinati dalla violenza di Stato, ci dia oggi la possibilità di ricordare che quello per cui questi compagni hanno dato la loro vita era sentito, immaginato e razionalizzato come un assalto al cielo, un assalto ad una società capitalista fondata sullo sfruttamento, sulla divisione in classi, un assalto paziente basato su un lavoro di massa e di ribellione organizzata e su un immaginario che non aveva confini.
Per cui Claudio e Giannino, tutti questi nostri compagni e compagne assassinati dalla violenza di Stato erano e sono sognatori ma non solo, ribelli ma non solo, antifascisti ma non solo: comunisti e rivoluzionari erano e sono, infatti, le uniche parole che possono definirli, l’unica sintesi che crediamo possibile, l’unica possibilità per provare a raccogliere questo insieme di determinazione fino al sacrificio della propria vita, di lucida analisi, insieme alla capacità di provare rabbia e odio profondo per ogni ingiustizia, come anche amore smisurato per l’uguaglianza e la libertà.
Nessuna commemorazione: rilanciamo le lotte
Un’ affermazione, questa, che è anche un invito a ripartire da questa nostra storia. Una storia che è anche fatta di dolorose fratture e forti contraddizioni che nessuno può edulcorare ignorando o nascondendo i grossi errori fatti. Ma che rimane, sempre e comunque, una storia di movimenti che hanno cercato di interpretare quella fase dello scontro di classe, provando a costruire una necessaria soggettività politica che desse una progettualità complessiva alla conflittualità sociale diffusa prefigurando anche un altro mondo possibile e necessario.
Una pezzo di storia del movimento di classe italiano da cui ripartire riaggiornandone e arricchendone, sicuramente, le categorie e il livello di analisi, ma comunque sempre a partire dall’analisi materialistica della situazione odierna, che tuttora rimane un prodotto dello scontro tra le classi. Un nodo, quello tra capitale e lavoro che resta il motore della storia, al di là delle errate interpretazioni della falsa ortodossia m-l che propone fughe soggettivistiche (ogni compagno un partito diverso) in attesa del comunismo come un evento messianico, ma anche senza i finti modernismi che oggettivamente ostacolano la possibilità di rilancio di una progettualità ricompositiva e complessivamente anticapitalista. Una falsa modernità dell’analisi che, al contrario che ripropone vecchie soluzioni e antiche categorie che arrivano dalle pur rispettabili correnti di pensiero del socialismo utopistico premarxista e dalle tradizioni del cattolicesimo sociale. È come se correttamente proiettati in una ricerca di nuove forme di comunicazione, ci si fosse invece ridotti a cercare di rappresentare una “nuova alternativa” più leggera, moderna e presentabile. Un’ alternativa talmente più presentabile da essere, e spingere a praticare l’azione politica, su un piano di compatibilità con il capitale, proprio per aver introiettato un concetto tanto caro da essere utilizzato strumentalmente dall’apparato culturale nelle società a capitalismo avanzato e, cioè, la scomparsa del concetto stesso di classi e dunque l’impossibilità di una trasformazione radicale e completa dell’esistente da cui ancora discende solo un continuo e altalenante galleggiare sulla denuncia degli aspetti più fenomenici ed evidentemente tragici della barbarie del capitalismo.
La presunta modernità di questa analisi, non a caso trasversale, dalla ex-sinistra riformista, ai residuali partiti comunisti della sinistra pacifista ora extra parlamentare, fino ad ampi settori di quello che veniva considerato il movimento antagonista, basata sull’erronea sovrapposizione tra la demolizione della vecchia fabbrica fordista e la sparizione della classe operaia, torna a introdurre, oggi, presunti nuovi ma nello stesso tempo antichi soggetti sociali: poveri contro ricchi, moltitudini contro élite imperiali, spostando i piani da un conflitto di interessi inconciliabili tra loro ad un livello intrisecamente compatibile.
L’affermazione di questo concetto demanda ad una pacifica o radicale (ma è solo un problema di forme) generica pressione sul capitalismo che diventa a questo punto emendabile, trasformabile e controllabile con l’eliminazione delle storture e dei picchi di sfruttamento sull’uomo o sulla natura. Quando, al contrario, il perseguire l’unità della classe e la ricomposizione, sul terreno del conflitto a partire dalla materialità dei bisogni, dei nuovi protagonisti dei mille rivoli in cui l’organizzazione capitalistica del lavoro è scomposta, dovrebbe essere il prioritario obiettivo di massima in cui gettare ogni nostra potenzialità politica e organizzativa.
Ricordare i nostri compagni e compagne assassinati dalla violenza di Stato non può quindi voler dire solo ricordo o rabbia o dolore senza soluzione, perché questo porta solo a diffondere frustrazione e impotenza o al rincorrere ricorrenze o commemorazioni, e conseguentemente ad una sconfitta storica che si evidenzia nell’incapacità di provare a costruire un immaginario di trasformazione radicale dell’esistente, che guardi al di là del quotidiano, e che sappia essere collante e obiettivo finale strategico per ognuno di noi.
Senza una prospettiva complessiva, senza la prefigurazione delll’obiettivo massimo di una società radicalmente diversa dall’attuale in cui l’uomo nuovo del Che possa crescere, sperimentare e sviluppare nuove relazioni sociali, ogni atto politico diventa solo e esclusivamente atto resistenziale che riproduce solo la sopravvivenza di ceti politici o di strutture che potranno, così, dare solo segnali ma senza continuità di percorso, con il rischio molto, troppo forte di porsi all’interno del pantano della “compatibilità democratica”, al di là della possibile radicalità delle forme che lo scontro possa assumere. Per questo, pur praticandola, siamo sempre stati critici in relazione alla genericità di una logica che portava le realtà dell’autorganizzazione sociale a ragionare ed occuparsi solo di difesa degli spazi sociali, di antifascismo e di repressione trasformando questi elementi importantissimi, parte di una battaglia politica più generale, in una sterile e autoreferenziale difesa di posizioni, di nostri spazi, quasi per poter dire di essere ancora vivi, senza però provare ad intaccare minimamente le strutture economiche e di potere che generano fascismo, razzismo e repressione.
Oggi, ad esempio, la corretta esigenza di dare una risposta a questo pericolosissimo blocco delle destre sta inducendo molti a pensare ad una forma di becero frontismo (la logica perdente del meno peggio) per contrastare l’egemonia pseudo-culturale berlusconiana, e questo non fa altro che favorire l’impossibilità di ricostruire un immaginario che non passi attraverso un altro, ennesimo aggregato di centro-sinistra che spianerà la strada ad un altro governo delle destre e così via. La parte più retriva della borghesia nazionale ha lavorato in tutti questi anni per dare corpo e identità ad un blocco sociale anticomunista, unito da interessi corporativi in grado di affrontare complessivamente e frontalmente altre ipotesi di società, instaurando un regime di “democrazia autoritaria” basata su diversi e stratificati livelli di controllo sociale.
Il fenomeno Berlusconi non risulta vincente solo per il possesso della stragrande maggioranza dei media e la conseguente possibilità di condizionare e plagiare l’informazione politica, ma soprattutto per l’uso che è stato fatto di questi media per imporre modelli comportamentali che hanno portato alla vittoria e alla egemonia pseudo-culturale di chi questi modelli meglio incarnava. Non possiamo, quindi, pensare di rincorrere o mutuare la genericità dei modelli di futile “modernismo” proposti dal potere per utilizzarli in senso antagonista, non possiamo pensare di abbassare la qualità delle nostre analisi per “aggregare di più” su qualcosa che rimane indefinito e nel migliore dei casi “progressista” o genericamente “di sinistra”. Siamo tutti così sicuri che questo paghi, dopo anni di arretramento che hanno visto la stessa cosiddetta area dei centri sociali disfarsi pezzo dopo pezzo, proprio per una progressiva perdita di contenuti e per il rincorrere la chimera della “comunicazione” che si andava a definire così come priva di contenuti e che ha finito per portare solo qualche voto in più a qualche candidato “più vicino” ai movimenti?
La crisi profonda della prospettive degli apologeti del “capitalismo sociale” e della “sinistra” riformista aprono oggettivamente lo spazio per una profonda riflessione e modificazione delle strutture e l’assunzione di nuove responsabilità per una sinistra antagonista che si deve rifondare a partire dalle contraddizioni reali, dalle lotte, dalla quotidianità dello scontro culturale, politico, economico contro il capitale provando ad indicare complessivamente un’alternativa di sistema, e costruire punti di riferimento politici ed organizzativi stabili all’interno di percorsi di massa. Crediamo che questa fase sia molto difficile, ma non solo difficile per le nostre strutture politiche o per i compagni e le compagne che bene o male seguono i nostri percorsi, ma sia difficile soprattutto per tutti i proletari e le proletarie, noi inclusi, che saranno spremuti a fondo dal capitalismo per uscire da questa crisi strutturale. Una crisi finanziaria che è solo indice di una crisi strutturale del modo di produzione e che ci dice che nel prossimo futuro precarietà e flessibilità saranno sempre più gli elementi fondanti della vita di tutti noi e il nuovo “collegato lavoro” diventa esplicativo delle nuove modalità di assunzione di un mercato del lavoro sempre più a misura di profitto per i padroni andandosi a definire come un vero e proprio atto di guerra contro i diritti dei lavoratori.
Ed allora, se questa è la fase, bisogna aspirare ad uscire dalla marginalità e dalla pura sopravvivenza politica, e rimettere in gioco le nostre energie, la nostra intelligenza, il nostro cuore e la nostra determinazione, come parte di un movimento di classe, pur nelle sue nuove definizioni, che costruisca teoria, politica, analisi dialettica e pratica di massa riuscendo così a re-immaginare un’idea di società altra, nuova, completamente e radicalmente diversa dall’attuale. Ma per far questo bisogna ripartire da zero, ponendosi al di fuori dei paletti che la borghesia ci pone ed infatti, ad esempio, siamo assolutamente convinti che questo blocco sociale non si possa battere con una scheda in un’ urna, ma con la ricomposizione di un forte movimento di classe che a partire dal terreno concreto dello scontro sociale, metta al centro delle riflessioni e delle pratiche antagoniste la capacità di riportare all’interno di un unico fronte di lotta i vari settori di classe ed i protagonisti dei nuovi e dei vecchi lavori.
Per concludere queste riflessioni, davanti alle nuove responsabità del “se non ora quando?” che questa crisi dell’organizzazione capitalistica del lavoro ci pone, diventa evidente che il tenere alta la bandiera della coerenza e il coltivare i valori di un immaginario di rivoluzione sociale siano l’unica cosa che si possa fare, per non farsi risucchiare nello stagno dell’immobilismo o del velleitarismo o della rassegnazione davanti allo strapotere del dominio di classe (due facce della stessa medaglia) sapendo che questa responsabilità non ci può permettere ne scontare genericità, alibi o scorciatoie. E perche il conflitto di classe e la prospettiva di un cambiamento radicale della società tornino ad essere al centro delle nostre aspirazioni collettive, al di là della diversità delle tattiche e delle forme di comunicazione , vanno superati il settarismo politico, la settorialità ed i corporativismi economicistici, ricominciando a sporcarci, con reti collettive, le mani con la realtà e le sue contraddizioni e, come strutture territoriali, con il non fermarsi solo agli aspetti sovrastrutturali dello scontro, e soprattutto, (e questa differenza è sostanziale) affiancando alla pratica della controinformazione e dell’agitazione la scelta strategica di porsi all’interno delle contraddizioni, dei conflitti e dei soggetti sociali che queste lotte promuovono e praticano portando in queste determinazione e radicalità.
Questa è l’unico modo che conosciamo affinchè, Claudio, Giannino e tutti gli altri compagni e compagne assassinati dalla violenza fascista e di Stato continuino a vivere nelle nostre lotte.
A pugno chiuso !
I compagni e le compagne del Centro Sociale Vittoria
Milano, aprile 2010